Cerca

- SIMONE NICASTRO
- GIUSEPPE PROVENZANO
- IPUTRAP
- DOMENICO DI PIETRANTONIO
- THE SHADOW
- MAGNUS
- LUCA MAFFEZZINI
- STEFANO NICASTRO
- ALESSANDRO VAILATI
- STEFANO VALLI
- MARY PELLEGRINO
- DANIELE CATALUCCI
- ELISA AIRAGHI
- JACOPO BOZZER
- LAURA FLOREANI
- LA REDAZIONE
- PAOLO TOCCO
- MATTEO MINELLI
- ROBERTO BRIOZZO
- VLAD TEPES
- EVIL MONKEY
- ALVISE CASONI
- LEO GIOVANNINI
- MISCELLANEA (AUTORI VARI)
- MASSIMILIANO MANOCCHIA
- LUCA FRANCESCHINI
- NICOLA CHINELLATO
- STEFANO GALLI
“La storia,” dice Stephen Dedalus nel secondo episodio/capitolo di Ulisse, “è un incubo dal quale sto cercando di svegliarmi.”
Ci sono parecchie affinità tra l’erudito solipsismo del personaggio joyciano e quello pur sempre colto ma più ‘popolare’ di Steven Patrick Morrissey. Entrambi sbocciano in aspirazioni ribelliste – vuoi per vocazione, vuoi per necessità – agite tuttavia in modi affatto diversi: con l’esilio per il primo, con la clausura per il secondo.
Se, però, Dedalus, animato dalla forse un pò ingenua speranza giovanile di poter rinascere e realizzarsi come artista lontano dal provincialismo paralizzante di Dublino, sceglie l’esilio come luogo da cui declamare il suo non serviam, Morrissey, all’opposto, sceglie l’isolamento, il celibato, il romantico rifiuto della vita intesa come convenzione e prassi, e chiude fuori da sé, o meglio, fuori dalla sua camera da letto, l’amata/odiata Manchester e ne fa simbolo dell’”out there”, il ‘là fuori’ che rappresenta la vita reale fatta di stereotipi sociali, politici e soprattutto sessuali. “Ho provato a vivere nel mondo reale, invece che in un guscio, ma mi sono annoiato prima ancora di cominciare,” protesterà laconicamente in “Shoplifters Of The World Unite”. Non è impossibile intuire che entrambi coltivano verso la realtà un atteggiamento in certo qual modo snobistico.
La Dublino dei primissimi anni Dieci del Novecento non è certo la Manchester degli anni Settanta, e per quanto sia possibile continuare a tracciare più o meno utili paragoni, ne scaturirebbe un arido esercizio di mera accademia, probabilmente sterile, senza dubbio indisponente.
Basti quanto abbozzato poco sopra, al lettore, per farsi un’idea dei presupposti che sono a fondamento di quella che – lo si è detto fino alla nausea, eppure mai come in questi tempi di accozzaglie culturali, repetita juvant – sarà “la band più importante degli anni Ottanta”. Certo, i presupposti di cui sopra non sono i soli, ché bisognerebbe narrare d’una Gran Bretagna ridotta quasi alla fame dalla Thatcher (uno dei bersagli preferiti di Morrissey: “The kind people / have a wonderful dream / Margaret on the guilotine”); di una scena musicale dominata dall’edonismo e dal culto dell’immagine (l’inizio degli Eighties coincide con l’espolosione del synth-pop e del cosiddetto movimento New Romantic, nato nei club londinesi e portato alla ribalta internazionale da gruppi come Visage, Duran Duran e Spandau Ballet); di patetici residui, o sarebbe più corretto dire “residuati” rimasti ibernati nel ’77, annus mirabilis, se non altro per popolarità, del punk, che tuttavia già all’epoca del fin troppo mitizzato incontro tra Morrissey e Johnny Marr – secondo quanto narrano le ‘sacre scritture’ avvenuto nell’autunno del 1982 – pareva secoli addietro; di una sessualità ostentata in modo triviale, mercificata ad uso e consumo dei più pruriginosi e bassi istinti adolescenziali; di una diffusa ‘falsità’ percepita non solo come fake ma come mancanza di autenticità.
Tratteggiato sommariamente, ne convengo, è comunque questo lo scenario in cui nacquero gli Smiths, inglesi fino al midollo eppure capaci come nessuno prima di loro (e forse neanche dopo) di parlare il solo linguaggio universale comprensibile a tutti.
Nel terzo episodio di Ulisse (poi non me la meno più, promesso), quello dedicato al lungo monologo interiore di Stephen Dedalus, c’è una domanda che affiora qua è là e che a un certo punto viene resa esplicita: “Qual è quella parola nota a tutti gli uomini?” Naturalmente, Joyce non fornisce alcuna risposta. Ma tutto lascia supporre che la parola sia “Amore”. Di questo, in tutte le sue sfaccettature e in tutte le sue accezioni, parlano le canzoni degli Smiths: è il substrato creativo, la materia che ne plasma l’essenza e ne imprime la direzione. Amore e assenza d’Amore.
E non è forse “Hand In Glove”, 45 giri di debutto dei mancuniani, una delle più grandi e improbabili canzoni d’amore di sempre?

Più che importanti, gli Smiths furono indispensabili, una singolare mescolanza di eccentricità e irruenza, esibizionismo e dolcezza: un poetico inno all’estetica della sciatteria fiorito spontaneamente all’interno della “società dello spettacolo”. La ruvida bellezza dell’immaginario morrisseyiano, miracolo di funambolismo tra anelito romantico e realismo in bianco e nero, poggia sull’indefinito, o meglio, sul non-definibile, e acutamente sbeffeggia, sotto una pioggia di gladioli, il trucido machismo rockettaro regalando nel contempo fiera dignità agli emarginati, ai diversi, al disagio sociale di tutte quelle identità non riconosciute dalla “gente perbene” e per questo costrette ad abitare una realtà parallela (nel 1990, il Morrissey solista esemplificherà simbolicamente il tutto in “Piccadilly Palare”, brano il cui tema, la prostituzione maschile nella Londra fin de siècle nella zona di Piccadilly appunto, viene cantato utilizzando un particolare tipo di slang detto “polari”, retaggio d’epoca vittoriana della cultura gay).
Al ritmo di danze ambigue e languide pose maudit, Morrissey stanò da reconditi pertugi un esercito fino ad allora silenzioso di creature “altre”, le cui istanze di ribellione non trovavano risposte nelle ideologie standardizzate e standardizzanti, ma si realizzavano nell’autoaffermazione individuale del proprio essere “diversi”, nel senso di non-omologati. Il grande misunderstanding iniziale (in parte voluto e alimentato, tocca ammettere, dallo stesso Moz) degli Smiths come “gay band”- per non parlare della grottesca insinuazione di pedofilia che minacciò di comprometterne la carriera fin dall’uscita del loro primo 45 giri – fu in parte dovuto alla concezione popolare dominante, abilmente costruita nei secoli dai biascicapaternostri e che resistette fino all’alba degli anni Ottanta, di “diversità” intesa esclusivamente come orientamento sessuale. Gli Smiths ampliarono la nozione di “diverso” e mostrarono al mondo che i diversi erano la maggioranza.
Se “This Charming Man” può apparire inequivocabile anche a letture successive, brani come “What Difference Does It Make?” e “Reel Around The Fountain”, rifiutando orgogliosamente di fornire qualsiasi riferimento di genere, rimangono non meno ambigui che sfolgoranti. Quest’ultima - fonte, assieme a “Handsome Devil” (b-side di “Hand In Glove”), di non pochi grattacapi per i quattro mancuniani, costretti a sbracciarsi fino all’esaurimento fisico e nervoso per evitare uno scontro frontale coi tabloid bacchettoni che li accusavano, come accennato poc’anzi, di apologia della pedofilia – è soprattutto la tenerissima, amara lamentazione di un perdente avvinto a un amore clandestino, colto nell’istante in cui prende coscienza della propria sessualità. Nel canzoniere degli Smiths, la poetica della (tras)formazione è narrata attraverso antinomie talvolta inconciliabili, a partire dall’attrazione/repulsione per la fisicità, anche intima, che diventa veicolo di riflessioni sulla condizione umana e sulla società, spesso cesellate in pungenti epigrammi che rimandano direttamente a Oscar Wilde, la cui influenza su Morrissey sarebbe palese anche senza le ammissioni di quest’ultimo.
Eppure Morrissey non è l’erede di Wilde, come molti vorrebbero credere, né un dandy dei nostri tempi. Gli yellow nineties rimangono un periodo unico e irripetibile che aveva edificato la sua ragion d’essere proprio sull’unicità e sulla “irripetibilità”, e il celebre The Yellow Book fu una sorta di Bibbia (irriverente, scandalosa, cinica) critica dei valori vittoriani dall’interno. Da un punto di vista puramente estetico, la posizione di Morrissey può definirsi come antagonista e quindi all’opposto rispetto a quella di Wilde e degli esteti di fine Ottocento. (Per inciso: Oscar Wilde non pubblicò mai nulla su The Yellow Book).
Tralasciando il goffo travisamento che da sempre si attua del concetto di dandy (certa critica ideologica, ad esempio, che disconosce D’Annunzio come uno dei maggiori innovatori della lingua e uno dei più grandi artisti che l’Italia abbia mai avuto) e la confusione pressoché totale tra “dandysmo”, estetismo e Decadentismo, l’evidenza dell’estraneità di Morrissey rispetto a queste tre “categorie” (o “stili” di vita) la si può facilmente desumere tanto dal suo aspetto quanto dai suoi scritti.
A parte qualche obliquo riferimento (gli “18 months hard-labour” di “I Started Something I Couldn’t Finish”, ad esempio – che, in realtà, per Wilde furono ventiquattro) e qualche timida citazione (la “flower-like life” di “Miserable Lie”, espressione tratta dal “De Profundis”), l’influenza wildeiana è rintracciabile soprattutto nelle interviste e principalmente in quelle del biennio ‘83/’84, agli esordi degli Smiths. È qui – più che nelle sue opere – che Morrissey esprime energicamente la sua verve e il suo improbabile talento di brillante conversatore che si compiace di fulminare gli sprovveduti giornalisti con eleganti mot d’esprit.
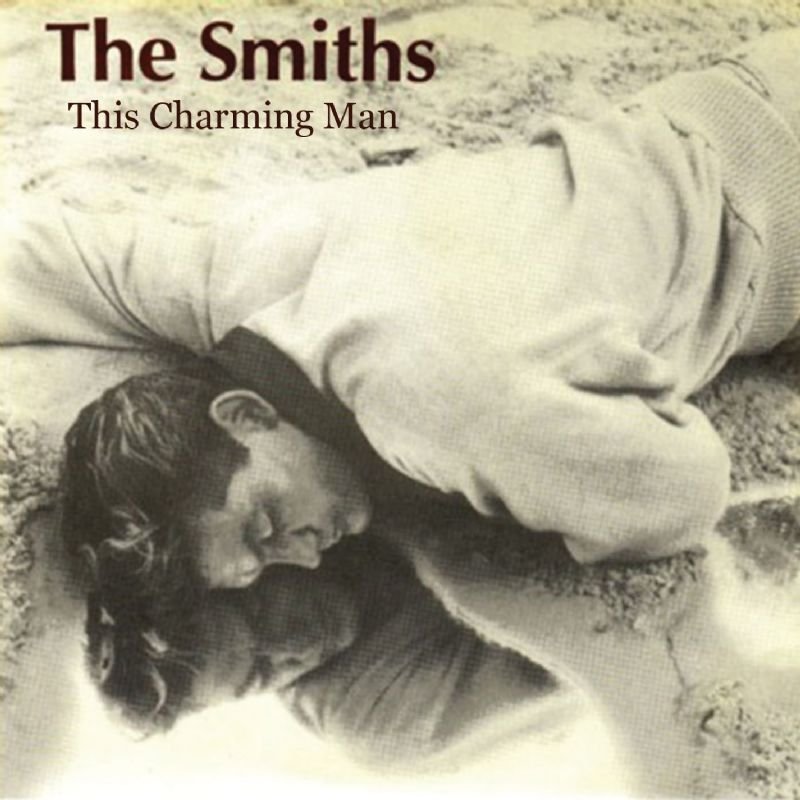
Bastasse questo a far di Morrissey l’erede di Wilde, si potrebbe allora affermare la stessa cosa per centinaia di altri artisti. È pur vero, tuttavia, che l’atteggiamento dell’ex-cantante degli Smiths ricalca consapevolmente le pose e le attitudini provocatorie dello scrittore irlandese (si noti che anche Morrissey è di origini irlandesi), benché la sostanza dei contenuti sia profondamente diversa. Laddove Wilde usa il paradosso satirico, e quindi la “leggerezza”, per evidenziare e sgretolare un po’ alla volta l’ipocrisia vittoriana, Morrissey non si fa scrupoli a colpire di vanga per molestare il Sistema, thatcheriano e non.
C’è poi la questione della vita come opera d’arte, tema caro all’Estetismo europeo, ma lontanissimo da Morrissey. A sentir parlare lui e quei pochi “eletti” che gli stanno attorno, la sua è da sempre una vita di clausura e celibato, cosa che non si può dire per Oscar Wilde, che fu figura di spicco nella mondanità europea e allergico all’astinenza sessuale non meno che alla stupidità umana (di entrambe si faceva beffe, ed entrambe furono la sua condanna).
In sintesi, mi pare di ravvisare in Wilde un approdo alla polemica sociale attraverso la critica estetica, mentre in Morrissey leggo una critica sociale (e, spesso, di classe) piuttosto diretta che talvolta si trasforma in polemica estetica; né potrebbe essere diversamente, se è vero che l’epoca in cui si vive e le condizioni sociali all’interno delle quali si nasce sono i primi due pilastri formativi dell’essere umano. Vive in entrambi l’idealismo del martirio (benché anche qui vi siano differenze sostanziali), ma se nel primo è vissuto come vocazione (e predestinazione) a un fato nefasto, nel secondo è più un’aspirazione alla diversità a tutti costi, che si manifesta con l’ambiguità sessuale, ad esempio, di “Pretty Girls Make Graves”, o (soprattutto da solista) politica, come in “The National Front Disco” e “Bengali In Platforms”.
Quintessenza – ancorché critica - della britishness novecentesca, la produzione del quartetto mancuniano (così come del Morrissey solista) è densissima di citazioni, riferimenti, rimandi - e talvolta implicite “congetture” - a un universo socioculturale e letterario non sempre intelligibile a chi british non è.
Letteralmente saccheggiata, ad esempio, la drammaturga Shelagh Delaney e la sua prima opera A Taste Of Honey, tassello fondamentale – come egli stesso afferma nella sua autobiografia - della formazione di Morrissey (la omaggerà per ben due volte: le copertine della raccolta Louder Than Bombs e del singolo “Girlfriend In A Coma” recano la di lei effige), il quale dichiarò candidamente: “Non ho mai fatto mistero del fatto che almeno il cinquanta per cento delle ragioni per cui scrivo sia da attribuire a Shelagh Delaney.” La messa in discussione dei concetti di razza, classe e genere è il nucleo centrale di A Taste Of Honey e di, essenzialmente, tutte le canzoni degli Smiths. La già citata e straordinaria “Reel Around The Fountain” copia e incolla il verso “I dreamt about you last night, and I fell out of bed twice”, mentre la torbida eppur dolce “This Night Has Opened My Eyes” (da cui, per inciso, Jonathan Coe ha tratto il titolo del suo terzo romanzo) è una vera e propria parafrasi in versi di alcuni elementi narrativi del kitchen sink drama della Delaney.
Altre citazioni (elencarle tutte sarebbe pleonastico) letterali o adattate si possono rintracciare in tutto il catalogo smithsiano. Eccezion fatta per alcuni nomi noti anche al grande pubblico (a James Joyce e Oscar Wilde, di cui s’è già detto, vanno aggiunti almeno Goethe, che “regala” un titolo – “At Least I Am Born” – al Moz solista, Jack Kerouac anch’egli “donatore” di un titolo – “Pretty Girls Make Graves” –, D.H. Lawrence che aleggia su “Handsome Devil” con la locuzione “a boy in the bush…” e il verso “who will swallow who”, e ancora Herman Melville, Marcel Proust, Shakespeare, John Keats, Graham Greene…), la più parte dei peculiarissimi rimandi e riferimenti rimane faccenda complessa e intricata, spesso volutamente oscura, tanto da trasformare la poetica morrisseyana in un vero e proprio codice linguistico cifrato per iniziati, e ostico per critici ed esegeti indolenti che si sono più volte trovati dinnanzi a testi la cui chiave interpretativa, senza i riferimenti di cui sopra, poteva sì aprire qualsiasi porta a proprio piacimento e comodo, ma col rischio elevatissimo che fosse quella sbagliata: la già menzionata controversia sulla presunta pedofilia ne è grottesco emblema, così come talune canzoni (“Panic”, ad esempio, clamoroso gioiello glam degli Smiths uscito nel 1986, o la già menzionata “The National Front Disco” apparsa sul terzo album solista del cantante, Your Arsenal del 1992) non meno ambigue che coraggiose, capite poco e male, per non dire strumentalizzate ad hoc da certa stampa, anche italiana, tuttora prigioniera di quella banale superficialità ideologica fin troppo conveniente che identifica come “fascista” l’amore per la propria terra.
Si aggiunga il fatto che Morrissey è da sempre vegetariano (il secondo LP della band – che nel 1985 scalzò Born In The U.S.A. dalla vetta della classifica inglese - s’intitolava per l’appunto Meat Is Murder) e ha dichiarato a più riprese di amare gli animali più degli esseri umani, ed ecco il perfetto simbolo del “fascista vegano”. Miracoli del Pensiero Unico. Polemiche a parte (ma si può dire di Morrissey senza tirare in ballo polemiche, controversie e ambiguità?), collocare oggi gli Smiths in una prospettiva storico-culturale confacente al loro status leggendario non è impresa semplicissima, e ancor più complesso sarebbe provare a spiegare a chi non c’era che cosa essi rappresentarono per la decade – gli ’80 – probabilmente più bistrattata della popular music.
A trent’anni dal loro scioglimento è tuttavia possibile evidenziarne qualità e carenze senza farsi travolgere dallo tsunami emotivo che allora si abbatté su gran parte della gioventù europea (gli Stati Uniti ne rimasero coerentemente immuni), sottoscritto compreso. E se di carenze si vuole parlare, tanto vale citare almeno la più evidente: per quanto il giudizio di fan e critici sia spaccato tra The Queen Is Dead (1986) e il canto del cigno Strangeways, Here We Come (1987), un vero e proprio grande album gli Smiths non ce l’hanno lasciato. O meglio, sì, ma si tratta di una raccolta, vale a dire quel Hatful Of Hollow che, tra singoli, b-sides e brani incisi per i programmi di John Peel e David Jensen, li coglie nel momento di massimo splendore e sfrontatezza a cavallo dell’eponimo (e sofferto) debutto a 33 giri. Miracolo di gaudio aurale e sunto di prodigiose intuizioni, Hatful Of Hollow è uno scrigno di gemme che rifulgono di bagliori indecenti (le scabrose allitterazioni di “These Things Take Time”) , ammalianti (la perfezione di “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want”), politicamente scorretti (la sibillina “William, It Was Really Nothing” o l’infingarda “Heaven Knows I’m Miserable Now”), o semplicemente illuminanti (“How Soon Is Now”).
L’universo del “miserabilismo” morrisseyiano è tutto racchiuso qui, in queste sedici magnifiche tracce. I successivi album (compresi quelli da solista) saranno lenti d’ingrandimento sul particolare, ne evidenzieranno dettagli e sfumature, definiranno con maggior precisione quei tratti che magari erano solo abbozzati, allargheranno gli scenari dell’azione al di là delle mura della camera da letto, ma poco o nulla di veramente nuovo aggiungeranno a quanto fin qui (siamo nel novembre del 1984) prodotto.
A chi avesse voglia di approfondire gli argomenti appena accennati in questo articolo (che, per ovvie ragioni, non può essere esaustivo e che intende soltanto stuzzicare e incuriosire chi degli Smiths ha solo sentito parlare o conosce appena quella manciata di canzoni entrate nel “canone rock”), consiglio di procurarsi (non sarà facilissimo) almeno due testi fondamentali, purtroppo mai tradotti in Italia, entrambi di Simon Goddard: Songs That Saved Your Life: The Art Of The Smiths 1982-1987 e il monumentale Mozipedia: The Encyvlopedia of Morrissey And The Smiths; per quanto attiene al versante puramente biografico, i due testi da possedere sono Morrissey & Marr: The Severed Alliance di Johnny Rogan e il più recente A Light That Never Goes Out: The Enduring Saga Of The Smiths di Tony Fletcher. Da segnalare anche i testi – notevoli – di un paio di autori italiani: Morrissey & The Smiths: Gli Ultimi Inglesi di Daniele Cianfriglia, uscito per i tipi di Stampa Alternativa, e A Murderous Desire di Diego Ballani, pubblicato da Arcana nella bella collana “Testi commentati”.
Infine – ma solo per i fan terminali come il sottoscritto – non si può non citare il capolavoro di Mark Simpson, Saint Morrissey, tradotto in Italia sempre da Arcana.
