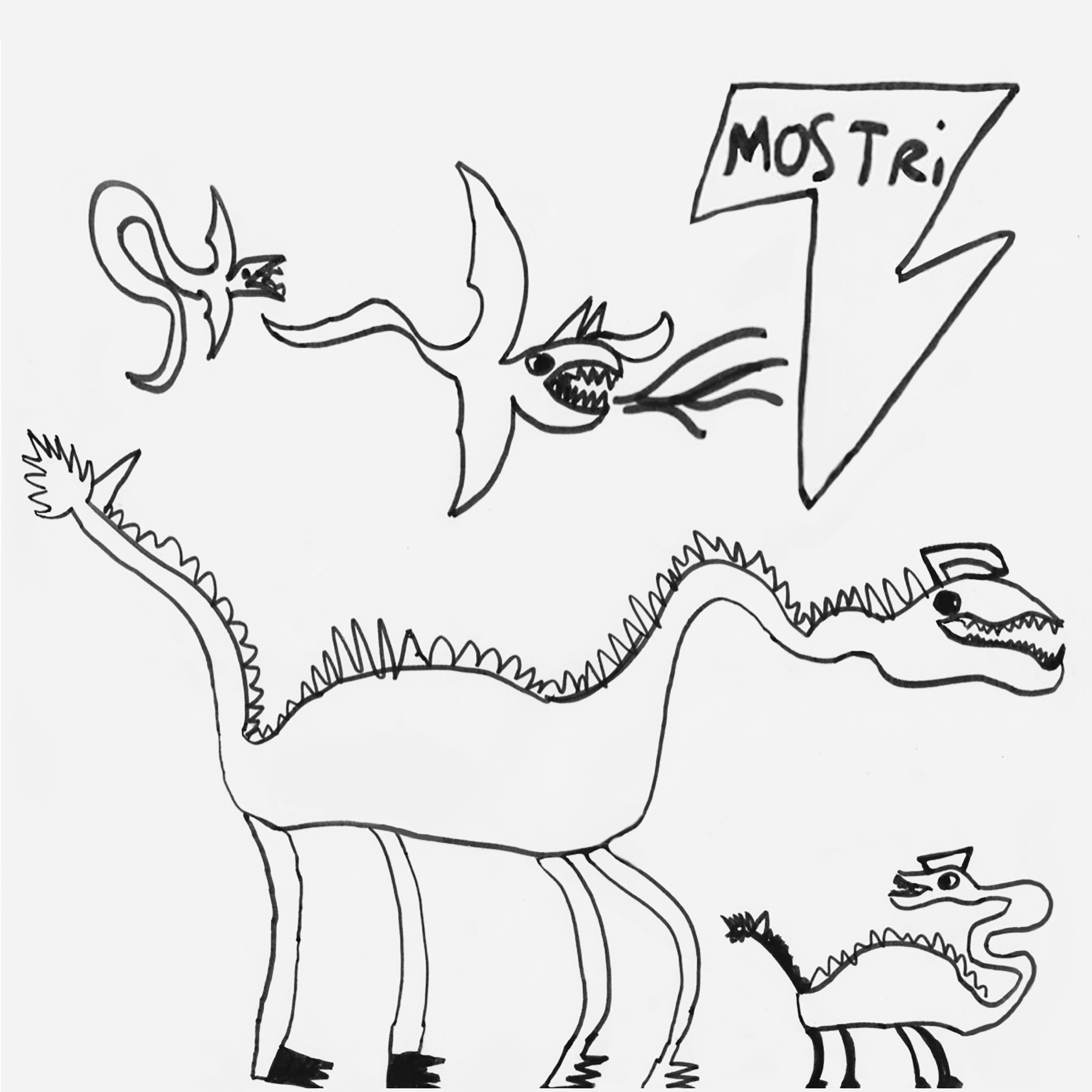Cerca

- SIMONE NICASTRO
- GIUSEPPE PROVENZANO
- IPUTRAP
- DOMENICO DI PIETRANTONIO
- THE SHADOW
- MAGNUS
- LUCA MAFFEZZINI
- STEFANO NICASTRO
- ALESSANDRO VAILATI
- STEFANO VALLI
- MARY PELLEGRINO
- DANIELE CATALUCCI
- ELISA AIRAGHI
- JACOPO BOZZER
- LAURA FLOREANI
- LA REDAZIONE
- PAOLO TOCCO
- MATTEO MINELLI
- ROBERTO BRIOZZO
- VLAD TEPES
- EVIL MONKEY
- ALVISE CASONI
- LEO GIOVANNINI
- MISCELLANEA (AUTORI VARI)
- MASSIMILIANO MANOCCHIA
- LUCA FRANCESCHINI
- NICOLA CHINELLATO
- STEFANO GALLI
Non saprei cos’altro aggiungere alle belle parole di Franco Naddei. Ho seguito diversi suoi lavori che ha condotto nei panni di produttore. Tra tutti, ho amato davvero quel progetto chiamato Santo Barbaro e quel disco che è “Navi”. Ma non è solo questa la storia. Al tempo si faceva chiamare Francobeat… oggi è semplicemente lui, Franco Naddei. Ed è un percorso di conoscenza personale, di consapevolezza che termina con la faticosa quanto dolorosa tappa della riconoscenza del sé. Come guardarsi allo specchio: un musicista reinventa il suo linguaggio, ne scopre angoli e si illude lo sguardo come può, prova e disfa, costruisce per poi cambiare faccia un istante dopo. Fa male riconoscersi, che spesso significa anche rinunciare ad un gusto o ad alcune trovate estetiche prese in prestito o peggio ancora rubate a chi prima di noi le ha messe in scena. Significa anche far pace con le proprie ombre. Così Naddei asciuga il suo personalissimo suono per creare silenzi dentro cui rifugiarsi e studia e incontra e spulcia e seziona con un bisturi di spiritualità le canzoni dei grandi maestri ma senza l’effimero desiderio di farsi latore di un passato sicuramente vincente agli occhi della Generazione Y. Non si tratta di omaggiare, non ne ha bisogno e non ne hanno bisogno neanche questi mostri sacri. Invece Naddei intraprende un viaggio di sintesi e di bellezza personale semplicemente, per quanto possa esserlo, con lo scopo di riconoscersi. E non serve aggiungere altro.
Si intitola “Mostri” questo nuovo progetto che affida alla rete digitale e che custodisce cinque grandi canzoni firmate da Tenco, Ciampi, CCCP, Battiato e De André. Lui ne asciuga l’estetica che codifica a suo modo rispettandone il DNA, l’ossatura, l’essenza e il sangue che continua a scorrervi dentro. E se glielo chiedete vi dirà:
“Non ho scelto Gaber, non ho scelto Dalla, non ho scelto De Gregori, non ho scelto Faust’o, non ho scelto Fossati, non ho scelto Modugno ma non per demerito (e ho citato autori a cui ho pensato ma ce ne sarebbero mille altri). Ho scelto il vestito che mi sentivo calzare meglio, tutto qui”.
Riconoscersi. Forse è questo il vero motivo che ci spinge a diventare sempre altro…
In genere cerco sempre di andare tra le righe delle canzoni ma questa volta devo procedere tra le righe di ciò che a queste canzoni hai chiesto. Ecco una domanda che secondo me è importante: alle canzoni di questi grandi artisti, una volta “fatte tue”, che cosa hai chiesto?
In realtà non c’è stato bisogno di chiedere nulla. Le canzoni, una volta scelte, mi hanno dato esattamente quello di cui avevo bisogno. Ho scelto proprio le canzoni che trovavo calzarmi addosso, a volte anche sverniciandomi con le loro frasi così intimamente connesse con quello che sono e che vivo. Le vere canzoni, come i veri amori, non chiedono. Danno incondizionatamente. Ed ho scelto proprio in virtù di questo amore le canzoni con cui sapevo non avrei litigato. Ho provato con altre canzoni, come fossero state altre donne, ma alla fine sono rimasto fedele a quelle che mi hanno saputo dare quel senso di appartenenza e di appagamento nel cantarle, nel viverle.
Se avessi chiesto avrei fatto un disco di merda. Certe cose non si chiedono, come l’età alle signorine, per esempio.
Probabilmente sono state loro a scegliere me!
Nel gergo popolare, almeno da noi, i “mostri” sono i grandi, sono coloro che hanno saputo fare grandi cose, spesso quelle più sceniche, quelle più esemplari. Pensando agli artisti che hai scelto direi che la definizione riporta… anche se mi aspetto ci sia altro visto che non hai pescato proprio l’opera più sfacciata ed evocativa di questi grandi… hai fatto una scelta di cesello artigiano… questo mi interessa capire…
La parola e l’autorevolezza nell’usarla sono state la chiave di tutto. Quando definisci un “mostro” pensi a qualcosa, o qualcuno, a cui ambisci arrivare, che osservi per rubargli le trovate più emozionanti, che studi approfonditamente per carpire quella magia che sai di non avere in quella misura. Sono tempi in cui spesso sento dire che ci si ispira all’uno o all’altro grande cantautore, ma spesso in funzione del fatto che è figo citare il tale, che è bello farsi paladini del recupero di qualcosa che è andato perduto e che val la pena riproporre. Ecco, qui non c’è niente da riproporre, non ci sono omaggi o tributi. C’è una bellezza oggettiva che riconosce alla canzone la sacrosanta funzione di saper coinvolgere il proprio ascoltatore, di sapere come raccontare quello che ha vissuto e che hai vissuto anche tu, autore che hai scritto la canzone. Il ruolo dell’artista viene sempre visto come qualcosa di astratto, ma mai come in certe canzoni il concreto del vissuto ti fa capire che il vissuto di uno che scrive canzoni è lo stesso di chi le ascolta. Chi le ascolta spesso non sa come raccontarlo, chi le scrive invece sì. Fare i retroguardisti mi fa abbastanza orrore. Dire che una volta era tutto meglio è sbagliato. Ora è semplicemente tutto diverso, e le storie che abbiamo nelle canzoni “moderne” non sono altro che il riflesso del tempo in cui sono state scritte, anche se cercano di guardarsi indietro nei retaggi linguistici, nei riferimenti e nelle citazioni.
Io non posso riconoscermi in una canzone scritta oggi se non per cause fortuite, più spesso sento che la mia storia è fatta di altro e si riconosce in canzoni, in autori, in storie che inevitabilmente rappresentano il mio tempo, sia anagrafico che artistico.
La scelta artigiana, come la definisci tu, è stata mossa dal fatto che avevo a disposizione un panorama autorevole enorme a cui guardare e non è stato semplice. Se “Mostri” fosse stato un tributo al cantautorato italiano nel suo complesso avrei dovuto fare almeno 4 volumi da 20 pezzi ciascuno. Non ho voluto fare scelte tributando qualcuno ma solo capire, parola per parola, cosa mi emozionava nel cantarle, e così ho fatto.
Non ho scelto Gaber, non ho scelto Dalla, non ho scelto De Gregori, non ho scelto Faust’o, non ho scelto Fossati, non ho scelto Modugno ma non per demerito (e ho citato autori a cui ho pensato ma ce ne sarebbero mille altri). Ho scelto il vestito che mi sentivo calzare meglio, tutto qui.
Chi ha messo le mani con te in questo lavoro? Troviamo anche un voce femminile e… cos’altro?
“Mostri” è un lavoro basato proprio sulla ricerca del mio suono, sullo stringere il campo che Francobeat invece vedeva allargato per via del fatto che pensava che i concetti potessero tenere insieme tutto, ho lavorato in totale autonomia ed autarchia. La voce femminile è di mia moglie, Sabrina Rocchi, che ha una voce meravigliosa che non usa mai. Ha cantato tanto in passato anche a livelli piuttosto alti ma poi ha smesso e mi ero ripromesso di volerla nel disco. In fondo “Mostri” contiene molti brani che hanno a che fare con l’amore, il suo evolversi, il suo autodistruggersi, il suo muoversi intorno alle cose della quotidianità. Il brano di Ciampi sembrava scritto per noi e volevo che lei fosse parte di quella storia come a renderla ancora più nostra ed ancora più vera, almeno per noi.
Suoni cupi, atmosfere a lume di candela… se mi concedi una sintesi. Ma il mood che mi arriva ha il sapore del silenzio… ho l’impressione che in questi grandi brani tu abbia ricercato spazio e silenzio per ritrovarti… sbaglio?
Dici cose sacrosante. I miei riferimenti sono sempre dettati da quello che ho fortunatamente incontrato nei miei ascolti di adolescente. I primi che mi vengono in mente sono i Talk Talk e Mark Hollis che mi hanno traghettato dalla musica di consumo a quella di ricerca, alla sperimentazione, alla sottrazione. In “Mostri” ho proprio cercato di trovare un mondo che posso definire adulto, maturo. Ho ormai 47 anni e son praticamente 30 anni che faccio musica. Francobeat era un confusionario-visionario-eclettico e credeva nei tanti generi, nel gioco tra il suono della parola ed il suono dei dischi in cui veniva inserita.
Ora ho voglia di poche cose, crude, in faccia, senza filtri. Ho lavorato ai pezzi con pochi strumenti: un paio di sintetizzatori ed una batteria elettronica suonando e cantando per capire se potevo sentire le canzoni che avevo scelto come veramente mie. Spesso ho lavorato di notte proprio perché di notte il rumore di fondo si abbassa ed i dettagli, soprattutto della voce, sono limpidi.
Ho ritrovato il gusto del linguaggio elettronico che mi è sempre appartenuto e che spesso ho dato, da produttore, in dischi di altri (penso in primis ai Santo barbaro ma anche altri che usciranno dopo questa intervista). Ed ho ritrovato il gusto del gioco anche se condotti da oggetti che non appaiono carnali come una chitarra, un basso o una batteria, ma che io intendo come tali e come tali li ho utilizzati. Per me l’elettronica ha un volto estremamente sanguigno e vivo.
In questo suono mi sono ritrovato e nel futuro vorrò farlo crescere al servizio di brani originali. Ho cose da dire che vorrei raccontare così, sfidando il rumore di fondo col silenzio e il battito pulsante del sentirsi vivi e creativi.
Un’altra cosa che ho sentito sulla pelle è uno strano bisogno di cercare altre forme da dare alla tua espressione. E se da una parte mi è sembrato incoerente visto che hai pescato brani già editi e quindi già formati, dall’altra l’ho trovata un'azione assai forte. Il cercare altre forme per trasgredire la loro buccia estetica… non se mi sono spiegato bene. Cioè trovo facile voler trasgredire partendo da zero… lo trovo più significativo dal punto di vista spirituale operando su qualcosa che ha già una sua forma… che ne dici?
Non so cosa sia più facile. Io questa cosa dei “Mostri” l’avevo intesa proprio come bieca ricerca di un sound che prima non avevo mai avuto, o perlomeno non in senso estetico stretto. Non mi sono mai potuto definire un artista elettronico perché mettendo avanti i concetti (con Francobeat) avevo sempre giocato con le forme e gli stili. L’idea di prendere delle belle canzoni, magistralmente scritte e con testi clamorosamente aderenti al mio vissuto mi ha permesso di impossessarmene definitivamente anche in senso sonoro. Chiaramente ci ho dovuto mettere una certa dose di incoscienza, ma quello fortunatamente mi riesce abbastanza facile! Lavorando da produttore ed arrangiatore per altri ho capito che una canzone ben scritta ha un corpo nudo pressoché intoccabile, ma il vestito lo puoi cambiare come vuoi senza turbare troppo quello che era in origine. Facendolo con una certa sensibilità si rischia anche di svelare contenuti del corpo originario che erano stati tenuti un po’ nascosti, proprio per decoro e rispetto verso questa sottrazione che rende affascinante un brano che si fa scoprire nel dettaglio a poco a poco. L’esempio più eclatante è rallentare i testi dei CCCP facendone capire bene le parole che in origine erano state lanciate dentro quell’impianto punk italico che tanto diede loro fortuna ed efficacia comunicativa. Pensare di smontare De André dalla sua aurea mitologica e portarla in una landa futuristica alla Blade Runner dove le sfumature della poesia si intrecciano con quelle dei suoni che ne sottolineano la fisicità e l’ossessività razionale del pensiero che tenta di descrivere un amore tortuoso, quando non fedifrago, è stato molto divertente.
Non c’è nessun desiderio effettivo di trasgressione ma una semplice ammissione del limite delle possibilità che potevo dare nell’interpretare brani non miei, e ne è scaturito un qualcosa che li fa sembrare ancora più miei, non so se mi spiego.
La parola… quanto è importante per te la parola? Oggi è una cosa che ha pochissimo spazio e a cui viene data pochissima attenzione…
La parola è fondamentale nel mio percorso. Ho sempre cercato di fare dischi dove le idee, le parole che le esprimevano e raccontavano erano centrali. Per certo ho sempre cercato la via della parola come espressione della fantasia, in tutte le sue sfaccettature. Posso dire che Francobeat, nella sua discografia, ha prodotto una specie di trilogia della fantasia. La fantasia ribelle della beat generation italiana in “Vedo beat”, la fantasia strutturata, poetica ed autorevole di Gianni Rodari in “Mondo fantastico”, la fantasia fuori controllo dei disabili mentali che hanno scritto i testi di “Radici”. Poi ho lavorato (e lavoro) molto sui Reading e spettacoli in cui la letteratura la fa da padrona. Penso a “Centurie” di Manganelli sonorizzato con John de Leo, alle collaborazioni con Le Belle Bandiere di Elena Bucci e Marco Sgrosso due attori enormi nel nostro panorama teatrale. Insomma per fortuna ci sguazzo dentro anche al di fuori della sola forma canzone.
Ma tornando a Naddei la volontà è quella di cominciare proprio dalla parola autorevole dei grandi che hanno saputo usarla con amore e rispetto ed imparare il piacere possibile. Ho scelto i brani proprio leggendo il solo testo della canzone, a volte ancora prima di conoscere il contesto sonoro con cui era accompagnata in origine. Un modo molto divertente per ascoltare i testi delle canzoni che ti appaiono ancora più diretti, nudi.
E quindi il mediatico di turno ti chiederebbe: nel tempo della parola maltrattata perché sei partito da lì? Un progetto che, direbbe sempre lui, altamente improduttivo visto l’andamento del pubblico...
Qui c’è un po’ da mettersi le mani nei capelli, tra verbi sbagliati e sgrammaticature varie sui social, frasi sconnesse e senza senso per attirare hype sul web, canzoni con evidenti errori grammaticali al loro interno. Insomma, non sarò laureato ma spero di poter contribuire a stabilire un linguaggio che sia il più bello ed autorevole possibile. Ho studiato e sto studiando questi “mostri” anche per questo motivo.
Spesso mi ritrovo a parlare di efficacia delle canzoni, sia in termini sonori che testuali. Chi scrive canzoni, e non è ancora emerso al pubblico che sia grande o piccolo, spesso si pone la domanda di come piacergli per ottenere ascolto, gradimento, magari vendere dischi (che oggi direi possiamo tradurre in vendere musica col tipo di mercato che ci ritroviamo oggi). Ecco, lì bisogna stare molto attenti. Il pubblico va rispettato, non si fa nemmeno prendere in giro tanto facilmente e spesso, da quel poco che ho capito s’intende, è molto lineare e ti costringe a ragionare.
Se alle masse piacciono i tormentoni spagnoli estivi dove le parole usate sono 7 in tutto non è un problema, nessuno si aspetta che quella data canzone possa arricchire spiritualmente chi la ascolta, e la stessa cosa può capitare con brani italiani che hanno sì e no 3 parole e magari qualche grugnito.
È solo un fatto di scelte che però vanno fatte con estrema convinzione, sincerità e naturalezza. Al massimo ti diranno “bello, ma non è il mio genere” (cosa che peraltro mi è capitata spesso!).
Io ho sempre fatto cose con un pensiero molto pop e aperto ma mi son sempre ritrovato nelle nicchie. In queste nicchie però ho trovato gli stimoli ed il gradimento di un pubblico che mi ha permesso di essere qui ora, di avere ancora voglia di fare dischi miei e di lavorare con impegno a dischi di altri sempre cercando di mantenere un occhio alla cosiddetta qualità e se vogliamo anche a stimolare i contenuti, gli argomenti trattati nei dischi, il modo in cui si vanno a scegliere anche delle cover da fare. Alla base di tutto c’è sempre la domanda: “hai qualcosa da dire?”. Se la risposta è sì val la pena farlo, che sia molto produttivo o meno. Spero sempre che il pubblico si allarghi all’improvviso non per smania di successo ma per quantità di teste che posso vedere ai miei concerti, più sono più spero di lasciare qualcosa di utile; che sia il ricordo di quel momento, una frase che li ha colpiti, la storia che c’è dietro al disco che sto suonando.
Fare 6 milioni di ascolti su Spotify mi farebbe mettere in tasca sì e no qualche centinaia di euro, non so quanto possa voler condizionare il mio modo di scrivere che oltretutto potrebbe comunque non arrivare a quel risultato.
Una volta se venivi preso da un discografico ci si arrabbiava perché volevano cambiarti tutto in funzione di quanto avresti venduto, e spesso erano veramente in grado di farlo, per cui poteva anche valerne la pena. Oltretutto lo facevano anche in funzione di un rispetto per il pubblico che comunque non avrebbe bevuto tanto facilmente una cosa fatta e pensata coi piedi, anche se trattava di musica estremamente commerciale.
Oggi non c’è molto da perdere per quelli come noi che stanno in trincea per cui meglio godersi la possibilità di rimanere se stessi e di non perdere il filo di quello che si vuol dire per inseguire qualcosa che, nella migliore delle ipotesi, non ci cambierà la vita in chissà quale modo.
Chiudo. Ti lancio una freccia poi vedi tu… Tenco, Ciampi e tutta la compagnia che stai puntando… secondo me è soprattutto questo il vero beat italiano…
Ho sempre pensato che il beat italiano, quello della beat generation s’intende, fosse nato dalla volontà di rompere le regole e stabilire un nuovo concetto di libertà che allora era veramente in crisi. Il modello americano fu importato con la solita decade di ritardo e coincise col periodo del boom economico italiano e con la ventata di aria fresca che finalmente si respirava dopo la guerra. È naturale che in quel periodo si sono formate molte delle coscienze artistiche che poi sono cresciute e che hanno influenzato molto il panorama “libero” italiano.
Probabilmente cerco ancora chi ha cercato di rimanere fedele a quella linea di libertà e sincerità. Che sia beat o meno.