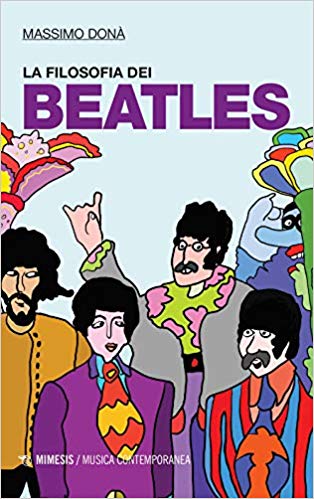Cerca

Docente di Filosofia, filosofo di vita ma anche musicista di quel jazz che mi aspetto essere poco accademico. Penserei subito ad un Miles Davis e di come lui appunto traeva dal conosciuto lo stimolo e la competenza per rivoluzionarlo, riscriverlo, dargli una nuova codifica ed una nuova veste. Ed ecco ricollegarci a questa bellissima frase che principalmente mi ha colpito rileggendo le risposte che Massimo Donà ha restituito alle mie domande come sempre troppo estese per il giornalismo di facciata e troppo lisergiche per il consumismo del qui ed ora:
“Il sapere di non sapere comporta infatti che un sapere sia comunque posseduto; ché solo di un sapere effettivamente posseduto, possiamo cominciare a dubitare (negandone appunto l’apparente solidità).”
Ho letto, anzi divorato, questo nuovo libro della splendida collana curata da Mimesis Edizioni: incontro e scontro tra filosofia e grande musica, quella che ha riconfigurato il mondo conosciuto senza altro da aggiungere. Si intitola “La filosofia dei Beatles” e in queste 164 pagine circa Massimo Donà sveste i Fab Four e li ri-assembla come fossero un puzzle di cartone, passando in rassegna tutti i contorni, i colori e le singole sfumature.
Inesistenza del reale ma anche decostruzione del significato oggettivo. Solitudine come costrizione da cui risorgere e poi personalizzazione (o emancipazione che dir si voglia) della singola espressione. Dal primo concept album della storia, da quel Sgt. Pepper in cui Geremy/Lennon aiuta a sconfiggere i Biechi Blu, dai Beatles tutti assieme quindi al grande Bianco da cui l’insieme diviene pian piano un oltre concettuale e fisico che deve aversi quanto prima… e comunque di oltre si parla sempre raccontando dei Beatles e dei loro dischi, di quella dimensione altra che è stata linfa vitale per i quattro di Liverpool, un modo di concepire la musica e l’espressione che prevede e anzi pretende (cito testualmente) “…un processo di vera e propria emancipazione della “differenza” e di coraggiosa liberazione dal giogo della rappresentazione”.
Massimo Donà ci regala un libro facile da leggere ed estremamente importante nei suoi contenuti, che riesce a snellire e a rendere accessibili nell’immediato anche per chi come me vive a giorni e giorni di cavallo dal mondo dei pensatori.
Eppure, non so descrivere il fascino che trovo nel ritrovarmi ora in casa dischi che fino a ieri ascoltavo per compiacere quel senso mitologico e che ora invece percepisco con un occhio più attento a sfumature di significato e concetti che in fondo, ma solo in fondo sia chiaro, erano “semplicemente” vitali per la genesi di quel disco stesso. Che volete che siano. Ed io li ignoravo. E scusate la presunzione: ma penso che come me anche il 90% delle persone che ascolta Sgt. Pepper, non sappia neanche chi siano i Biechi Blu. E forse va bene così.
Davvero credo sia questa una delle interviste più belle e costruttive che abbia mai avuto l’onore di fare. Un grazie pubblico a Massimo Donà.
Vorrei cominciare da un concetto che torna attuale sempre. Pare assurdo ma al tempo stesso è di una realtà quasi drammatica: parlo di come si possa celebrare un mito assoluto come quello dei Beatles e saperne davvero poco se non addirittura niente. La lettura di questo libro, la chiave con cui lei ha codificato lo scenario produttivo dei quattro di Liverpool mette in luce aspetti portanti, anzi determinanti ma che sono assolutamente estranei alla massa… massa che poi è il vero cuore pulsante della vita di un mito. Per farla breve: ho l’impressione che tutti conoscano “Sgt. Pepper” ma che pochissimi siano coloro i quali sappiano davvero di cosa parli, tanto per fare un esempio. Allora mi chiedo, anzi le chiedo: il mito di cosa vive in realtà? Da cosa viene riconosciuto? Cantiamo tutti “Lucy In The Sky With Diamonds”: ma non è assurdo che quasi nessuno sappia di cosa parli? Quindi cos’è che la rende immortale secondo lei?
I Beatles sono diventati un mito; un mito della modernità – nessuno, credo, potrebbe negarlo. Ma cosa significa, anzitutto, diventare un mito? Potremmo cominciare col rilevare che “diventare un mito” significa anzitutto diventare un’icona che continua a parlarci e a coinvolgerci ben oltre l’epoca storica del suo effettivo costituirsi. Vi sono molte figure storiche che, col tempo, hanno dimostrato di poter vantare una tenuta da veri e propri miti. Un mito sono diventati ad esempio Cleopatra, James Dean, Cesare e Leonardo da Vinci. Ma miti sono diventate anche molte figure letterarie, frutto dell’umana immaginazione. Mito sono diventati, cioè, Ulisse, Antigone, Don Chisciotte, Re Artù ma anche Robin Hood. Mitica è Alice come mitico sarebbe diventato il Paese delle Meraviglie, ma mitici sono anche Pollicino e il Mago di Oz. Insomma, si diventa miti quando i confini storici entro i quali si è venuti alla luce non limitano più la portata effettuale delle proprie azioni e delle simbologie dalle medesime chiamate in causa. Il mito, cioè, parla un linguaggio universale, che trascende sempre la determinatezza storica di questa o quella vicenda esistenziale. E dunque quel che un certo personaggio storico può essere stato realmente può non essere ritenuto affatto decisivo in rapporto al costituirsi come tale da parte del mito. Anche perché le determinazioni storiche di quello che riconosciamo come “un mito”, col tempo, vengono inevitabilmente dimenticate; i loro contorni diventano sempre più vaghi e offuscati, e rimane il senso metastorico che, solo esso, diventa realmente “mitico”. Perciò, a ben vedere si è determinati dai miti anche là dove poco o nulla si sappia dell’opera o della persona evocate da questa o quella vicenda mitica; ad esempio, tutti parlano del complesso edipico, anche se pochissimi – credo – sanno qualcosa dell’Edipo re o dell’Edipo a Colono di Sofocle. Allo stesso modo i dischi o le canzoni dei Beatles agiscono ancora oggi (e potentemente) sul nostro immaginario, per quanto poco o nulla (purtroppo) si sappia delle loro canzoni, dei testi e delle armonie che li supportano.
Sartre della solitudine ne ha decantato la nausea. Lennon invece l’avrebbe raccontata con l’ansia di chi deve assolutamente fuggire da una prigione?
Certo, perché Lennon non era un esistenzialista. È vero: Lennon viveva le stesse sensazioni e le stesse emozioni messe a tema dalla grande filosofia francese della metà del Novecento. Ma ne faceva esperienza in modo totalmente diverso; nulla a che fare, cioè, con Sartre, Camus, Cioran e la banda di amici che frequentavano il Café de Flore. Lennon, in questo senso, è assai più vicino al nostro Leopardi. Non si crogiolava infatti nella nausea provocata dall’incombenza di un non-senso vissuto come condizione originaria dell’esistenza umana. Non ne faceva oggetto di uno sguardo sistematizzante e astratto – e in questo può anche assomigliare ai pensatori francesi –, ma, rispetto al loro malcelato snobismo, il suo era un patimento reale; come quello di Leopardi, appunto. Entrambi avrebbero fatto qualsiasi cosa per uscire da quella condizione… se fosse stato possibile. Come fecero, di fatto, trovando un certo sollievo solo nella pratica artistica; unico modo, ai loro occhi, per adeguarsi all’insensatezza della vita, senza interrogarla e neppure pretendere che risponda alle nostre presuntuose domande da meri uomini della conoscenza.
Parliamo di anni caldi come quelli a cavallo del ’68. Anni in cui i Beatles si avviano alla conclusione della carriera. Secondo lei tutto questo periodo di cambiamenti e di trasformazioni sociali ha influito in qualche modo nell’emancipazione di ciascuno di loro?
Ma certo! Diciamo però che l’influenza, se c’è stata, è stata reciproca. Da un lato, senz’altro, essi hanno respirato la nuova aria che cominciava a soffiare in quegli anni; la loro innata porosità li avrebbe oltremodo aiutati a registrare quel che di nuovo andava agitandosi nel mondo. Ma furono anche loro a spingere il proprio tempo sempre più decisamente in una certa direzione. A fare in modo, cioè, che quelli che sarebbero anche potuti rimanere dei semplici germogli (destinati ad appassire come spesso accade alle piante, senza una quantità di acqua e di sole sufficienti a farle fiorire), riuscissero a fiorire come i ciliegi in Giappone; modificando concretamente lo stile di vita e il modo di pensare delle giovani generazioni, e coinvolgendo in questa velocissima trasformazione il mondo intero. Senza le loro provocazioni e la potenza mediatica sprigionata delle medesime, il Sessantotto sarebbe anche potuto rimanere un fenomeno d’élite. E non credo di esagerare.
Le lancio una mia osservazione. Restando su questo tema io trovo assai coesi come concetti e come immaginario l’emancipazione sociale e il bisogno di ribellione e quel che è diventata la vita di Lennon dopo i Beatles. Mi appare nitida, se penso in questa direzione, la figura del “Nowhere Man” e mi arriva prepotente quella di Yoko Ono e quel loro modo di sfidare la comunicazione e il relazionarsi con e verso il pubblico… sbaglio?
Anche in questo caso concordo con lei; emancipazione sociale e ribellione hanno rappresentato due delle componenti più potenti della loro Weltanschauung. Soprattutto attraverso i proclami, le performance e i testi che avrebbero visto Lennon sempre in prima fila, insieme alla nuova compagna giapponese. A dire il vero anche McCartney – e non di rado – si espose, dal punto di vista sociale e politico, ad esempio rispetto alla difficile situazione irlandese di quegli anni. Forse, quello più attento a trasformarsi anzitutto interiormente era George Harrison; ma nel complesso direi che i Beatles, e in particolare la “ferma determinazione” di Lennon, hanno a loro modo sicuramente contribuito a sconfiggere le potenze negative che si agitavano in quegli anni sul globo terracqueo. Si pensi solo alla lotta di Lennon contro la guerra in Vietnam e contro le ipocrisie di una classe borghese sempre troppo comodamente seduta sul proprio faticosamente guadagnato benessere.
Ma in generale, pensando proprio alla separazione dei Beatles, pensa sia corretto parlare di emancipazione o forse dovremmo usare parole come personalizzazione o individualità? Credo, anzi spero che la domanda sia intelligente perché trovo che il limite che divide queste due parole sia davvero sottile…
Guardi, a questo proposito credo che il limite sia talmente sottile che possiamo tranquillamente parlare di una emancipazione dal ‘collettivo’ che ha senz’altro contribuito a fare emergere appieno la personalità di ognuno dei quattro. E dunque la loro individualità; che certo non rinunciava ad esprimersi all’interno del quartetto, ma in quella dimensione non poteva che rinunciare ad esprimersi appieno, in tutte le sue sfumature. Anche solo per una questione di spazio; pensi a quanto poco spazio veniva dato a Harrison nei dischi targati Beatles; e a quante e quali doti covava il più mistico dei quattro, come sarebbe apparso evidente con l’uscita di “All Things Must Pass”. Doti che solo in questo album triplo sarebbero riuscite a farsi riconoscere in tutto lo spettro da esse effettivamente attraversato. Fermo restando che il continuo confronto con gli altri tre aveva comunque permesso ad ognuno dei Beatles di completarsi e imboccare direzioni che da solo forse non avrebbe mai avuto il coraggio di percorrere. Pensi a quanti brani sono il risultato di una effettiva collaborazione tra loro; soprattutto tra Lennon e McCartney. A quanti brani, soprattutto a partire da “Sgt Pepper”, sono nati dall’unione di frammenti composti o dall’uno o dall’altro; che sarebbero comunque riusciti a confluire in un brano unico e perfettamente armonioso.
Di questo libro mi ha colpito tantissimo il concetto di destrutturazione. Il continuo rimando a quel bisogno di dissociare le cose dalla loro natura o addirittura parliamo di verità. Quindi dissociare il significato dalla sua verità o realtà. Cerco di spiegarmi come posso: ho trovato assai interessante e stimolante questo concetto di oltrepassare “le regole” per poter avere accesso ad infinite altre possibilità di lettura di una stessa cosa. Ma quand’è che quest’esercizio ci porta alla deriva della follia e del nonsenso e quando invece ci permettere una sensibilità artistica o un’estetica superiore?
Come sempre, è una questione di misura; lo sarebbe stato anche per i Beatles, che, in ogni operazione a suo modo destrutturante, hanno saputo salvarsi dalla sempre possibile deriva, ritrovando ogni volta il filo di una ispirazione che doveva condurli alla messa a punto di qualcosa di essenzialmente “nuovo”. Di straordinario. D’altronde, per ottenere risultati “straordinari” non ci si può limitare a seguire pedissequamente le regole dettate dalla tradizione e ad applicarle, magari con gusto, cercando di riuscire ad essere in qualche modo “originali”. Qui non si tratta infatti di originalità; perché con i Beatles cambia davvero tutto; nulla, cioè, avrebbe più potuto essere come prima. Anche moduli e stilemi ereditati dalla tradizione avrebbero saputo rideterminarsi e farsi radicalmente inediti. Anche solo per un piccolo particolare, per un arrangiamento, per l’uso delle voci, per un’armonizzazione imprevedibile. L’ho spiegato anche nel libro; i Beatles hanno utilizzato i materiali più diversi (da cui la natura quintessenzialmente “pop” della loro musica); ma hanno saputo comporli e confonderli in un plesso assolutamente unitario. Il loro. Un modo che avrebbe permesso di rendere ogni brano capace di restituire il timbro e la cifra, inconfondibili, dei “Beatles”.
E secondo lei, per quanto la follia super partes della produzione dei Beatles abbia sposato questa voglia di andare oltre dove tutto non è vero e non è falso, non è altrettanto vero che poi la forma canzone si appoggi comunque a dettami assai popolari e reiterati dal gusto oggettivo del fare una canzone? In altre parole, andare oltre le regole sì ma restandoci con le mani e con i piedi. Sembra quasi che sia solo la forma estetica superficiale a venir stravolta o a far finta di sembrare strana ma che poi l’essenza della canzone resti tale e quale a quella di tutte le altre… o sbaglio?
Qui, mi spiace, ma non sono d’accordo; perché l’eccezionalità della loro produzione deriva proprio dal fatto di aver saputo connettere e sintetizzare (come nessun altro avrebbe saputo fare) la “forma canzone” più tradizionale con suoni, strumentazioni, arrangiamenti e sperimentazioni acustiche di ogni genere. Anche quelle più avanguardistiche, in voga nel centro Europa di quegli anni. Ma anche negli Stati Uniti e in Italia. Troppo facile sperimentare il suono impossibile, inascoltabile, e utilizzare un’elettronica in via di velocissima espansione, senza preoccuparsi del canone; così come sarebbe troppo facile limitarsi a restare all’interno del canone, e lasciare a pochi sciamannati il gusto di colpire con frustate spesso sgradevoli le orecchie dell’ascoltatore. La vera sfida messa in opera dai Beatles è stata cioè quella di negare queste ‘astratte’ contrapposizioni; e mostrare che si sarebbe potuto fare musica in modo davvero nuovo, non riconducibile all’avanguardia dei vari Varese, Ligeti, Stockhausen, Berio e Nono, ma neppure alle canzoni in voga in quegli anni; dal melodico tanto amato in Italia alla canzone d’autore di provenienza francese. “Grazie dei fior” di Nilla Pizzi era una cosa; così come erano una cosa la pur jazzata “La Bicyclette”, resa famosa da Yves Montand, o “Quand on n’a que l’amour” portato al successo da Jacques Brel nel 1957; ma tutto ciò nulla ha a che fare con l’inaudito sound proposto dai Fab Four in brani come “Sg.Pepper’s Lonely Hearts Club Band” o “I’m Only Sleeping”, “Tomorrow Never Knows” o “The Fool On The Hill”. Composizioni il cui sound non ha nulla a che fare, in senso proprio, neppure con l’appena nato rock & roll. Nei Beatles c’era l’antico, ma c’era anche il “novissimo”, c’era l’effetto trainante del rock ma anche la sperimentazione più all’avanguardia. E spesso in uno medesimo brano.
E restando su questo tema ma estendendolo in uno scenario più sociale mi chiedo (e mi perdoni forse la leggerezza con cui forzo il concetto ma spero serva a farmi capire in modo diretto): ma questo oltrepassare le regole (regole estetiche più che altro) non significa anche anarchia? Come a dire: non so cantare ma chi l’ha detto che essere intonati è la verità, è la regola dell’arte? Dunque, bene anche io che sono stonato…
Beh, questo di “anarchia” è un concetto quanto mai importante; ma anche pericoloso. Sempre che non lo si intenda nel modo dovuto. Invito solo a riflettere su una cosa: l’alfa privativo, o meglio negativo, che precede il tema “arché” non dice affatto cancellazione di quel che si nega, ma per l’appunto sua semplice “negazione”. D’altra parte, che razza di anarchia potrebbe darsi là dove non vi siano regole o principi da negare? Che, in quanto realmente e concretamente negati, peraltro, devono anche essere necessariamente affermati. Altrimenti succede come a qualche musicista di mia conoscenza, che, con la scusa di non voler sottostare ad alcuna regola, non studiava lo strumento, non studiava armonia e fraseggio, dicendo di voler suonare “liberamente”; peccato che poi, non sapendo nulla della struttura della musica, finiva per fare sempre le stesse cinque note; quelle più facilmente eseguibili con il suo strumento. Il risultato, come si può ben immaginare, era di una noia mortale. Mancanza assoluta di imprevedibilità, di fantasia e di immaginazione.
Perciò la sfida perpetrata dai Beatles, quella che li muoveva a negare ogni volta i risultati appena raggiunti, e a fregarsene dei modelli vincenti all’epoca, faceva sempre tutt’uno con una perfetta conoscenza di quei modelli. E poi i Beatles non erano affatto stonati; eppur erano radicalmente an-archici; e proprio perché erano disposti ad abbandonare le regole del bel canto, ma solo quando l’avessero ritenuto opportuno. È vero; si può anche cantare con un filo di voce, si può sgranare la voce e renderla sorprendentemente roca, si può urlare, ma quando si vuole, si deve anche saper intonare una settima maggiore senza fare ridere gli ascoltatori. È la stessa cosa che si potrebbe dire di Socrate; il quale, certo, diceva di sapere “di non sapere”, ma non stava per ciò stesso dicendo di essere banalmente ignorante – come lo erano la maggior parte dei suoi concittadini. Il sapere di non sapere comporta infatti che un sapere sia comunque posseduto; ché, solo di un sapere effettivamente posseduto, possiamo cominciare a dubitare (negandone appunto l’apparente solidità).
Chiudiamo con la chiusa dei Beatles. E qui vorrei trascrivere il pensiero che trovo ad aprire l’ultimo capitolo di questo bellissimo libro. Un pensiero tratto da “Il sex appeal dell’inorganico” di Mario Perniola. Cito testualmente: “(la mia eccitazione si radica) …nel fatto che tanto la vita delle anime quanto la forma dei corpi è negata da un’affermazione più vasta e più estrema, che non si arresta presso una qualsiasi determinazione spirituale o sensibile, non si lascia bloccare dell’incanto di uno sguardo o dalla dolcezza di una carezza, ma li smentisce e persevera nel darsi come cosa universale che qui e ora tutto è capace risentire e far sentire”. Che sia questa la ricetta del mito che vivrà in eterno?
Sicuramente, questo bel frammento del caro e compianto Mario Perniola è particolarmente centrato; sicuramente, dice molto più di tante pagine polverose di estetica accademica. Ché, anche Mario era uno che sapeva sfidare i luoghi comuni, i preconcetti, proprio come i Fab Four; conosceva, certo, la tradizione filosofica, ma era impegnato a rinnovarla in continuazione, smentendone gli assunti, e cercando sempre quel che si sarebbe ancora potuto dire o comprendere… E così fa anche in queste bellissime righe, in cui evoca la potenza di un sentire non determinato ma capace di ravvivare ogni sensazione determinata, ed offrire alla medesima sempre nuova vita, dando ad ognuno di noi un vero e proprio compito… per il futuro. Come hanno sempre saputo fare i Fab Four.