Cerca

- US HARD ROCK UNDERGROUND
- REGGAE
- QUEBEC ROCK SAMPLER
- BLUES
- CLASSIC ROCK
- ALTERNATIVE
- CLASSICA
- HIP HOP
- ELETTRONICA/AMBIENT/EXPERIMENTAL/AVANT-GARDE
- HARD ROCK/HEAVY METAL
- ITALIANA
- PSICHEDELIA
- PROGRESSIVE / KRAUTROCK
- MASTERPIECES
- AMERICANA/FOLK/SONGWRITER
- POST-PUNK
- PUNK / HARDCORE
- POP
- JAZZ
- BLACK
- ROCK
- NOISE / GARAGE / INDUSTRIAL
La leggerezza, nel suo significato più esteso e distante dalla definizione che ne dà la fisica meccanica, dovrebbe essere una caratteristica intrinseca e importante della musica Popolare. Potrebbe addirittura considerarsi una discriminante rispetto alla musica così detta colta. Tanto quest’ultima è complessa, orchestrata, formalizzata e, perché no, pesante, tanto il Pop dovrebbe servire a veicolare emozioni di immediata comprensione e sentimenti di piacevole svago. L’espressione tipicamente italiana “musica leggera” eleva la qualità a categoria. Ma se questo pur generico assunto trovava buoni riscontri nel primo decennio di dominio del Rock n’ Roll, tra il 1950 e il ’60 su per giù, la via percorsa dal Pop e dal Rock degli anni successivi fu ben diversa. Cercando l’approvazione delle masse, ma ambendo allo stesso tempo allo status di artisti a tutto tondo, (e non più solo entertainer) cantanti e strumentisti hanno lavorato per colmare la distanza tra “musica popolare” e “musica colta”, cercando di uscire dall’adolescenza della forma-canzone e del 45 giri, per giungere ad una fase più matura costruita attraverso l’album, la poesia, il live show sempre più perfezionati e complessi. Non è più così scontato oggi applicare la categoria “leggerezza” al Pop e tantomeno al Rock, che anzi ha trovato nella scientifica ricerca della durezza prima, del peso poi, una redditizia linea evolutiva. Non esistono reali opposti ad “Hard Rock”, “Power Pop”, “Hardcore” e, soprattutto, “Heavy Metal”; se quindi il peso entra così prepotentemente non solo nelle singole canzoni, ma addirittura nei generi codificati, forse la leggerezza è oggi una qualità in estinzione. Forse non sarebbe nemmeno sbagliato leggere parte dell’evoluzione della musica Popolare degli ultimi 50 anni come un succedersi di addizioni di peso: aggiunte di db al volume, aggiunte di piste sul mixer, aggiunte di strumenti e sovraincisioni.
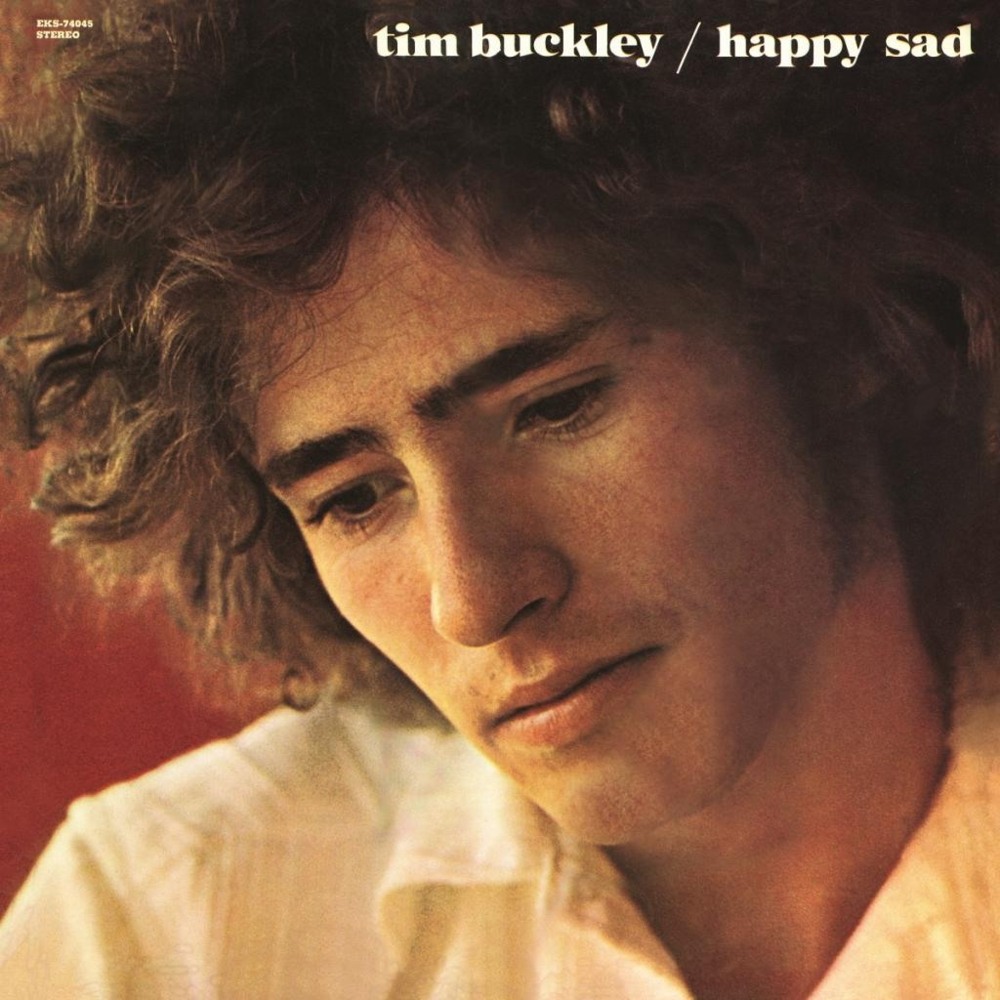
Se dovessi qui indicare un manifesto per la leggerezza in musica sarebbe una canzone remota e forse poco nota ai più: “Buzzin’ Fly” di Tim Buckley è la prima che mi salta alle orecchie. In questo pezzo del 1969 tutto congiura a favore della leggerezza: dalla meravigliosa linea melodica della chitarra di Underwood che sale e scende in barba alla gravità esplorando tutta l’estensione dello strumento; alla semantica stessa del testo in cui compaiono sostantivi lievi come honey, sand, seabird ed espressioni verbali altrettanto chiare come l’iterazione float away nonché il titolo stesso, con quell’essere per metà onomatopea e per metà dichiarazione di intenti musicali. La mancanza di una sezione ritmica lascia che il brano si sviluppi come un duetto tra chitarra e la voce controllata e, eccezionalmente, radiosa di Tim Buckley, cantante abituato a registri ben più mesti. Una leggerezza ottenuta attraverso la scrittura della musica e la fluidità dell’esecuzione, oltre che dall’uso delle parole.

È una leggerezza matura, ben diversa da quella più ingenua, tanto da sconfinare a volte nella superficialità, così tipica di certi anni ’50. Gene Vincent, per esempio, uno dei primi imitatori di Elvis, deve la sua iniziale fortuna allo stratagemma di togliere peso alle interpretazioni della superstar di Memphis. Con una presenza fisica ben diversa da quella Presley, Vincent punta su un sound di compromesso tra il Country e il nascente Rock n’ Roll e anche in questo caso è la perizia di un chitarrista a fare la differenza: Cliff Gallup fu uno dei massimi virtuosi del periodo e le sue brevi e velocissime scorribande soliste garantivano il salto di qualità ai brani di Vincent: “Bluejean Bop”, “Jump Back”, “Race With The Devil”, tutte scatenate, ritmate e velocissime, riescono a mantenere una lievità preclusa alla carica sessuale e sociale del baritono di Presley. Una leggerezza costruita con la fantasia, la velocità e una vocalità tenue e scoppiettante allo stesso tempo.
Dello stesso periodo mi ha sempre incuriosito la moda tipica dei gruppi vocali di attribuirsi nomi di uccelli: Cardinals (cardinali), Penguins (pinguini), Flamingos (fenicotteri), Ravens (corvi), Larks (allodole), addirittura Orioles (rigogoli) quasi come se il nome potesse essere il propellente per un sound facile e veramente leggero, melodioso come il canto dei pennuti. In effetti gli intrecci di falsetti e baritoni di sfondo faranno da trama importante per slanci tenorili memorabili, primi tra tutti quelli di Tony Williams dei Platters

Ben diverso l’apporto che dà alla nostra categoria una piccola canzone del 1968, leggera per elezione semantica sia del testo sia del nome del gruppo: “Light On Your Windows” è emblematica di quella speciale connessione che la lingua inglese ha tra il luminoso e il leggero. Light come sostantivo, luce, diventa light come aggettivo, cioè non pesante. Luce come mancanza di massa e dunque sola energia, un po’ come la musica stessa. Poco importa che il testo dei Quicksilver Messenger Service si riferisca a stanze luminose: il soffice tessuto musicale a base jazzistica alleggerisce ulteriormente l’impalcatura di un brano “elettromagnetico“ proprio nel senso che il fisico Maxwell diede del termine nelle sue 4 equazioni. Inevitabile un’ultima considerazione sul nome che il gruppo di Mill Valley scelse in omaggio a Mercurio (in inglese quick silver, argento veloce), messaggero degli dei e portatore dei sandali alati: la divinità volante e veloce per eccellenza.

Tra i protetti di Ermes, l’eroe Perseo si distinse per l’uccisione di Medusa, una Gorgone con il potere di pietrificare con lo sguardo. Un mostro in grado di rendere pesanti anche le più lievi delle creature. Numerosi furono i musicisti in grado di esercitare lo stesso potere, ribaltando la leggerezza e la mobilità in massa e ponderosità. Alcuni esempi ci vengono dai Nazareth, sempre in grado di rileggere brani, anche acustici, come potenti corazzate metal: “Ballad of Hollis Brown”, “This Flight Tonite”, “Shape of Things” tra le altre; eppure il loro non fu un potere del tutto malvagio in quanto conferirono un certo fascino ritmato a canzoni che di per sé così leggere non lo erano del tutto (la ballata di Dylan su tutte); il loro fu un personale tentativo di trapiantare la tipica matrice Rock anglosassone in territori da boogie sudista. In realtà la vera Gorgone del Rock anni ’60 furono senza dubbio i Vanilla Fudge. Un gruppo che letteralmente si nutriva di covers: delle 32 canzoni che compaiono sui 5 album pubblicati tra il ’67 e il ’70, qualcosa come 24 pezzi sono cover. Questi eterotrofi del Rock avevano il dono di tramutare in piombo qualunque onda sonora, che si trattasse dei Beatles, di “You Keep Me Hangin' On” delle Supremes, di Sonny Bono o della allucinante versione di “Season of the Witch” di Donovan. Ritmi rallentati, batteria rimbombante, organi da chiesa e cantati gregoriani; impossibile definirla “musica leggera”, eppure avranno proseliti, fortunatamente con idee più personali, nel Progressive e nel Rock da arena di fine ’70.

Eppure, nonostante questo tenace lavoro di appesantimento, il reale manifesto della sconfitta della leggerezza arriva, con l’immagine ancor prima che la musica, dal primo album dei Led Zeppelin: la tragedia dell’Hindenburg, in cui il fluttuante dirigibile viene distrutto da una nuvola di fuoco, segna il definitivo tramonto dell’era del volo leggero.
Se questo processo di pietrificazione ha fatto la fortuna di alcuni gruppi Hard & Heavy, il suo apparente opposto ha contribuito alla fortuna di Mtv in anni più recenti: il procedimento dell’”unplugged” è tanto più coinvolgente, quanto più arrabbiato e violento è in origine il gruppo che si propone senza elettricità. Ma la “sottrazione di peso” in questo caso è meramente di facciata e soprattutto di volume. “Smells Like Teen Spirit” non perde tutta la sua pesante emotività staccando il jack, e vedere i Kiss senza trucco o i Korn senza amplificatori sembra più il (buon) divertissement di una sera piuttosto che l’inizio di un nuovo corso. Almeno l’”unplugged” chiarisce una volta per tutte come non basti il solo dato dei decibel a decidere sulla pesantezza di una canzone, o di un intero genere.

Un tentativo curioso di spogliare il Metal della sua eponima “heaviness” lo tentò un insospettabile Mark Kozelek, già leader dei Red House Painters, quando pubblicò nel 2001 Who’s Next to the Moon, album acustico composto interamente da vecchie canzoni degli AC/DC. A chi si chiede come il taccuino da bassifondi di Bon Scott possa adattarsi allo spleen di Kozelek potrà sembrare strano che proprio i testi sono la cosa che meglio funziona nel progetto. Un tentativo di sconfiggere la Gorgone senza guardare nel riflesso che riesce solo a tratti (“Love Hungry Man”, “What's Next to the Moon”) e altrove viene pietrificato all’istante. Ma forse era un’impresa troppo ardua anche per un Artista come Kozelek, già avvezzo a costruire con la leggerezza la base per ben altre introspezioni. Almeno la prima fase della carriera dei Red House Painters è la ricerca costante del più tenue supporto per i più gravosi pesi di malinconia, depressione, solitudine, abbandono. Un “togliere” che in questo caso è vera e propria mancanza, e la raffinatezza delle canzoni sta proprio nel continuo meravigliarsi di come una suono così etereo, addirittura rarefatto, possa farsi carico di tali oneri. Sempre sul punto di rottura, la loro musica è come la tela su cui si dondola l’elefante delle filastrocche per bambini; un paradosso fisico che trova la sublimazione in brani come “Katy Song” o “Mother” talmente eteree da scomparire letteralmente in lentissime dissolvenze, che sono poi il continuo disfarsi del ricordo nella mente dell’Autore.
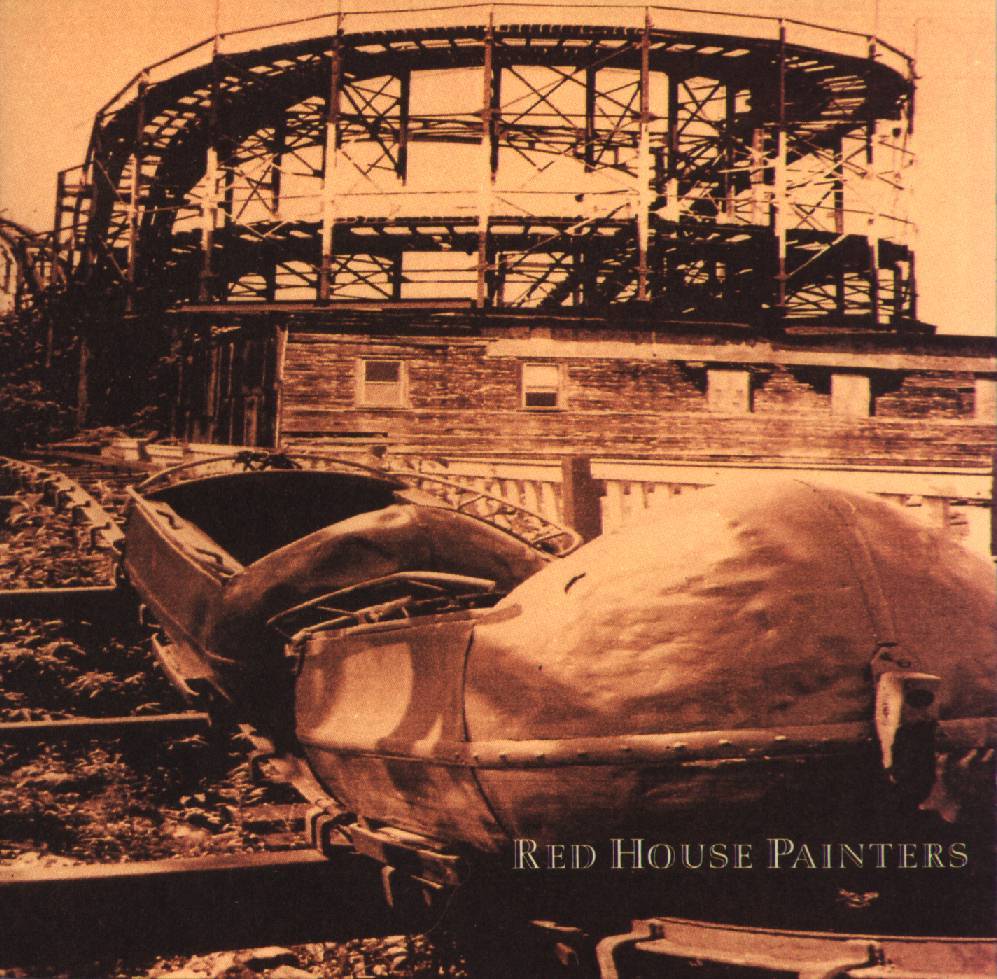
Non che l’estrema rarefazione corrisponda forzatamente ad estrema leggerezza; sotto quest’ottica l’opera omnia dei Sigur Rós potrebbe essere considerata un’ode alla nostra categoria. Questa è piuttosto la leggerezza della “piuma di Valery”, una leggerezza che è incerta e in balia di ogni brezza; diversa, per l’autore francese la leggerezza dell’uccello: “Il faut être léger comme l'oiseau et non comme la plume”.
Ad un terzo tipo di qualità, mediana rispetto agli estremi del poeta francese, si dedicò un illustre antenato di Mark Kozelek, quel Nick Drake che oggi è di moda citare come fonte d’ispirazione, ma che nel 1974 morì solissimo e ignoto ai più. Già il titolo dell’esordio, Five Leaves Left, riassume parte della sua poetica autunnale: la sua è la leggerezza della foglia che cade lieve ma dritta al suolo alla rottura del picciolo. Un momento in cui anche il peso di qualcosa ormai morto è troppo gravoso da sostenere: Drake è il cantore di quell’istante. Se il suo primo album fu illuminante, il terzo e ultimo, Pink Moon, è il tentativo struggente di non fare precipitare a terra quella foglia. Già dalla bellissima copertina surrealista, con oggetti improbabili che galleggiano nel cielo notturno. Ma se la “luna rosa” si può solamente guardare da lontano, tornano spesso parole come ground o floor: è la fragilità di un’anima che si allontana sempre più dalle cose del mondo. Distantissimo appare poi Drake nella voce che incide su disco. Una lievità sepolcrale e notturna; dunque, sia lieve anche la terra allo sfortunato artista.
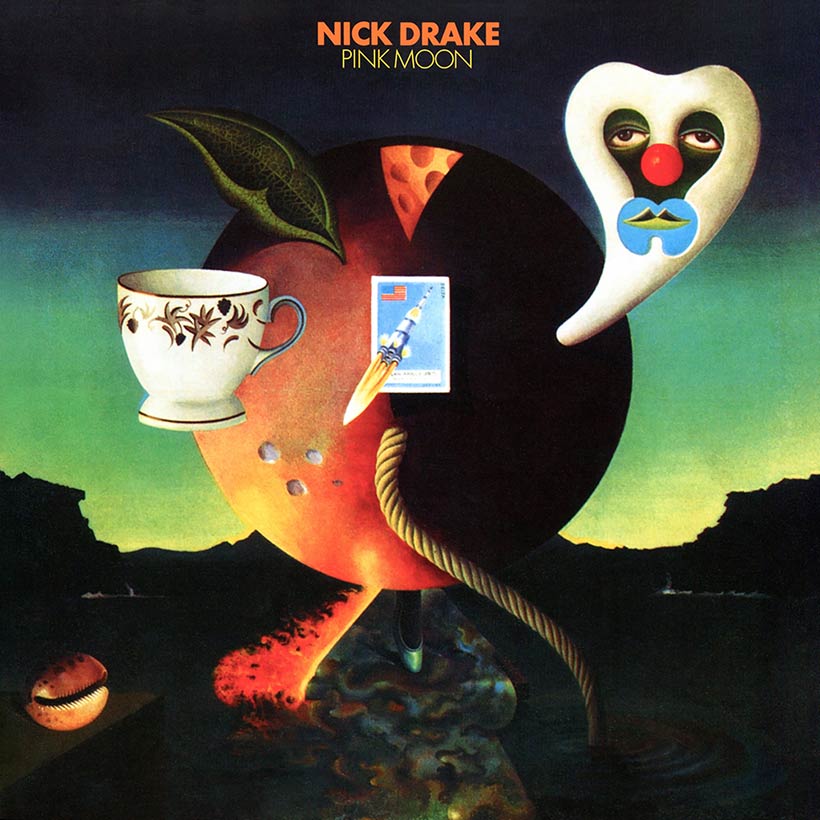
Per riemergere da questo lato oscuro vorrei tornare ad un contesto già accennato parlando dei Quicksilver, ovvero la grande stagione della West-Coast. Due gruppi in particolare hanno saputo cogliere una sfumatura essenziale: l’eleganza della leggerezza, quel fascino mai ostentato che trae il suo magnetismo dalla perfezione del prodotto. Spirit e Love furono complessi che della “grazia” e della classe strumentale fecero i propri cavalli di battaglia. Il gruppo di Randy California e Joy Ferguson ebbe un inizio di carriera folgorante con “Fresh Garbage” e per esteso tutto il primo album: cinque musicisti diversi ma complementari e intimamente affini, amalgamati da quel grande batterista che fu Ed Cassidy: alle sue ritmiche, complesse eppure immediatamente accattivanti, si deve quel misto di giovane impudenza e di elettricità controllata che pervade “Straight Arrow” o “Girl In Your Eye”.

Ancor più perfetti, elastici, ritmicamente impeccabili e musicalmente nitidi furono i Love, l’unico gruppo che riusciva a coniugare la carica del garage con la perfezione degli arrangiamenti in stile Brian Wilson. Forever Changes è il capolavoro formale di quell’arte quasi neo-classica ma vorrei qui soffermarmi su un brano dell’album precedente, Da Capo, che riesce a scrollarsi di dosso le pastoie dei luoghi comuni sulla canzone d’amore e restituirci un bozzetto caldo e intimista sulla relazione di coppia: “Orange Skies”. Piccole apparizioni come l’usignolo, lo zucchero filato e soprattutto i cieli arancioni, a cui il flauto toglie ogni materialità, tanto da lasciarle libere di fluttuare come bolle di sapone.

Il fluttuare è verbo soave e quasi musicale, una conseguenza della sottrazione di peso e materia a cose e idee. Da un punto di vista letterale i campioni della “fluttuazione” dovrebbero essere i musicisti più prossimi a quello strano genere che è lo “Space Rock”; in realtà, almeno nel mondo anglosassone, raramente questa forma Rock riesce a decollare veramente. Ben più ampio l’ultimo vero volo del qui già citato Tim Buckley che in Starsailor, offre la sua visione di un viaggiatore spaziale perso in verità più nell’inconscio che nel cosmo. Più facile incontrare veri esploratori stellari nell’Europa continentale: molti musicisti cosmici tedeschi hanno esplorato lo spazio profondo ma sempre a bordo di pesanti astronavi elettroniche.
Anzi, è paradossale che “Planet Caravan”, piccolo brano acustico dei Black Sabbath, i sovrani della materialità in Rock, riesca meglio di tanti altri a perforare l’atmosfera con tanta semplicità musicale. Trent’anni dopo i Kyuss renderanno omaggio al brano con una cover di concetto, “Space Cadet”, estesa fino a 15 minuti, acustica come un mantra dei primi Amon Düül. Più o meno nello stesso periodo anche gli Sleep diedero la loro versione del viaggio spaziale con “Inside the Sun”: uno dei brani più pesanti di uno dei gruppi più pesanti sulla scena.
Questa irrimediabile fatica di volare, così perennemente connessa alla gravità, trova in una produzione minore degli Helloween una allegoria involontaria ma intrigante: “If I Could Fly” fu un singolo di terza fascia all’inizio del 2001 e nel videoclip la scena chiave era rappresentata dal cantante Andy Deris che, appeso a due enormi e rigide ali di cartone, recitava una parte a metà tra Icaro e un rapace. Il bello della canzone stava proprio in quel periodo ipotetico (If I could…) che frustrava ogni tentativo di librarsi in volo; tentativo vanificato anche dalla musica stessa (e qui sta il bello dell’involontarietà…) non propriamente memorabile se non per una efficace introduzione di pianoforte. Un’evoluzione interrotta rispetto ai cieli sovrani di “Eagle Fly Free”?
Un’ immagine simile, ma dalla resa molto migliore, ce la fornisce Roger Dean, l’illustratore britannico la cui attività è sempre stata tangenziale al Pop (ma il suo ruolo nei successi degli Yes non va dimenticato). Gli elefanti volanti sulle copertine disegnate per il gruppo africano Osibisa sono la migliore celebrazione antigravitazionale che si possa trovare in un LP: sono gli “elefanti rosa” di Dumbo con la prerogativa tipica del protagonista. Da non dimenticare che lo stesso Dean fu anche l’architetto di quelle Floating Island, memori della Laputa di Swift e di molto Magritte, che forniranno ben più di una semplice ispirazione agli ideatori di Avatar.
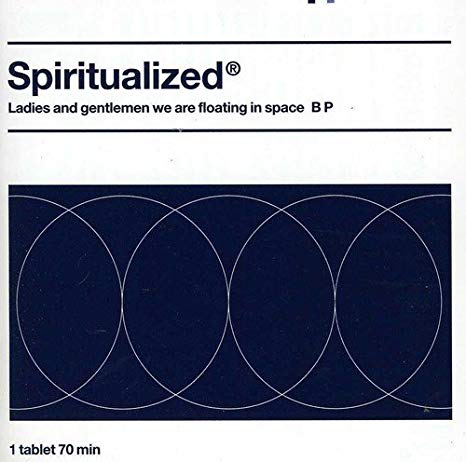
La verità è che in epoca moderna i campioni del fluttuare senza dubbio sono gli Spiritualized sia nella musica che nelle immagini dei testi. Pur carica di orchestrazioni stratificate e tecnologiche, il Rock di Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space è sempre etereo e leggero come l’elio, pervaso di soffice candore e privo di una meta precisa. Quella degli Spiritualized è in effetti una vera “macchina soffice” dove il suono è onnicomprensivo e pervasivo come la droga per la poetica di Burroughs.
Dal canto suo la “macchina soffice” più famosa della storia del Rock non era certo un esperimento soft, anzi il gruppo di Wyatt, Hopper, Ratledge (e anche di Ayers, e Daevid Allen) radunò alcune delle menti più argute e a loro modo sovversive nel panorama Pop. La musica dei Soft Machine ha molti più legami con il jazz e con l’arte astratta del primo ‘900 che con i fervori di fine anni ’60 che li videro comunque protagonisti. Una apparente leggerezza che è in realtà sintesi tale da arrivare al minimalismo e a suo modo è l’opposto degli orpelli barocchi e ponderosi di “equivalenti” sonori come gli Emerson, Lake and Palmer di Tarkus o Pictures at an Exibition. Il breve assolo di tastiere di “Priscilla” vale in questo caso più di tante parole.
Ripercorrendo questo vagabondare alla ricerca della leggerezza perduta mi sono imbattuto in diversi fili conduttori di questa categoria; una leggerezza che è qualità e ispirazione di una canzone (Tim Buckley, Love); una leggerezza che è sottrazione di peso (anche psicologico e culturale) e che spesso si confonde con la più facile fruibilità (Vincent, Penguin, Orioles); una leggerezza sonora che è una maschera per veicolare i più bui recessi di un’anima in sofferenza (Drake, Kozelek e a modo suo anche Tim Buckley); una leggerezza che è stile, perizia strumentale ed eleganza (Love, Spirit); infine eccone una “antinewtoniana” che è puro desiderio di volo, di levitazione, di viaggio antigravitazionale.
Concluderò ricordando due espressioni di leggerezza pura: un autore e una canzone. L’autore è Ray Davies, il musicista che più di tanti altri ha dato linfa a questa categoria, l’unico in grado di coniugare satira sociale, riflessioni sul cambiamento dei tempi e ironia ad una infinita semplicità e levità di scrittura (anche musicale); “Sunny Afternoon”, “Johnny Thunder”, “Celluloid Heroes” sono pesi piuma di densità culturale elevatissima.
La canzone è “The Weight”, che chiude idealmente il cerchio con “Buzzin’ Fly” citata in apertura. Questo brano di Robbie Robertson, così perfetto da essere un piccolo hit nell’affollato 1968, è anche uno dei migliori ossimori del Rock Americano, con la A maiuscola. Una ballata soffice in cui il peso del titolo viene svuotato di tutta la sua massa dalla meravigliosa batteria “a levare” di Levon Helm e dal pianoforte di Garth Hudson.
Take a load off Annie, take a load for free;
Take a load off Annie, And you can put the load right on me.
Se aiutati dalla musica, anche i gravi affanni della vita e dei suoi personaggi possono essere portati dentro uno zaino.


